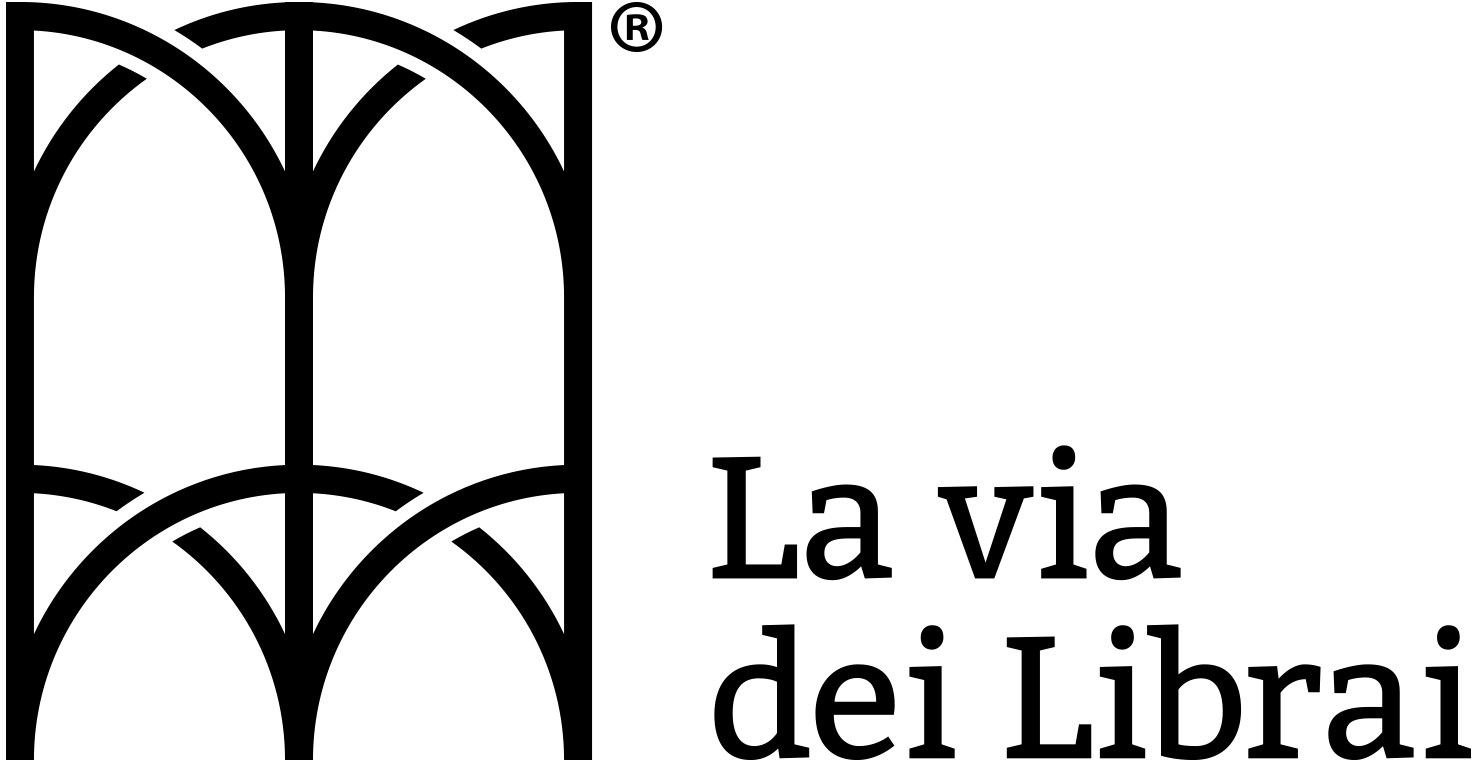Questo Sito Web è un servizio di:
Significa Palermo ETS - Viale Regione Siciliana 2253 - 90135 Palermo
Indirizzo email del Titolare: [email protected]
Da sapere a colpo d’occhio
- Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero essere solo applicabili ad
alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune disposizioni potrebbero applicarsi solo a Consumatori o
solo a Utenti che non agiscono come Consumatori. Tali limitazioni sono sempre menzionate esplicitamente in
ciascuna clausola interessata. In caso di mancata menzione, le clausole si applicano a tutti gli Utenti.
- Il diritto di recesso si applica solo nei confronti di Consumatori Europei.
CONDIZIONI D'USO
Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di questo Sito Web esposte in questa sezione hanno
validità generale.
Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente indicate in
questo documento.
Utilizzando questo Sito Web l’Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti:
- Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti
Professionisti;
Contenuti su questo Sito Web
Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su questo
Sito Web sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti.
Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su questo Sito Web non violi la
normativa applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale
risultato.
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono
pregati di indirizzare i relativi reclami ai recapiti specificati in questo documento.
Diritti sui contenuti di questo Sito Web
Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti
contenuti.
Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito nel
corretto utilizzo del Servizio.
In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere oltre i
limiti sotto specificati, modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere
sottolicenze, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal contenuto
disponibile su questo Sito Web, di permettere a terze parti di intraprendere tali attività tramite il
proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa.
Ove espressamente indicato su questo Sito Web, l’Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere
determinati contenuti disponibili su questo Sito Web esclusivamente per scopi personali e non commerciali ed
a condizione che sia osservata l’attribuzione della paternità dell’opera nonché l’indicazione di ogni altra
circostanza rilevante richiesta dal Titolare.
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore.
Accesso a risorse esterne
Tramite questo Sito Web gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti
riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde
del loro contenuto e della loro disponibilità.
Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali
concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e
condizioni o, in loro assenza, dalla legge.
Uso ammesso
Questo Sito Web ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti,
secondo questi Termini ed ai sensi della legge applicabile.
È responsabilità esclusiva dell’Utente di far sì che l’uso di questo Sito Web e/o del Servizio non violi la
legge, i regolamenti o i diritti di terzi.
Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri
interessi legittimi, ed in particolare di negare all’Utente l’accesso a questo Sito Web o al Servizio,
risolvere contratti, denunciare ogni attività censurabile svolta tramite questo Sito Web o il Servizio
alle autorità competenti – p. es. l’autorità giudiziaria o amministrativa – ogniqualvolta l’Utente ponga
in essere o vi sia il sospetto che ponga in essere:
- violazioni di legge, regolamenti e/o dei Termini;
- lesioni di diritti di terzi;
- atti che possono pregiudicare considerevolmente i legittimi interessi del Titolare;
- offese al Titolare o a un terzo.
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
Prodotti a pagamento
Alcuni dei Prodotti offerti su questo Sito Web come parte del servizio sono a pagamento.
Le tariffe, la durata e le condizioni applicabili alla vendita di tali Prodotti sono descritte di seguito e
nelle rispettive sezioni di questo Sito Web.
Descrizione del prodotto
Prezzi, descrizioni e disponibilità dei Prodotti sono specificati nelle rispettive sezioni di questo Sito
Web e sono soggetti a modifica senza preavviso.
Sebbene i Prodotti su questo Sito Web siano presentati con la massima accuratezza tecnicamente possibile,
la rappresentazione su questo Sito Web tramite qualsiasi mezzo (inclusi, a seconda dei casi, materiali
grafici, immagini, colori, suoni) è da intendersi come mero riferimento e non implica alcuna garanzia in
merito alle caratteristiche del Prodotto acquistato.
Le caratteristiche del Prodotto selezionato saranno specificate durante la procedura d’acquisto.
Procedura d’acquisto
Ogni fase, dalla scelta del prodotto fino all’inoltro dell’ordine, fa parte della procedura d’acquisto.
La procedura d’acquisto comprende i seguenti passaggi:
- Gli Utenti sono pregati di scegliere il Prodotto desiderato e di verificare la loro scelta d’acquisto.
- Dopo aver controllato le informazioni visibili nella scelta d’acquisto, gli Utenti possono effettuare
l’ordine inoltrandolo.
Invio dell’ordine
L’invio dell’ordine comporta quanto segue:
- L’invio dell’ordine da parte dell’utente determina la conclusione del contratto e fa sorgere in capo
all’Utente l’obbligo di pagare prezzo, tasse ed eventuali ulteriori oneri e spese, così come specificato
nella pagina dell’ordine.
- Nel caso in cui il Prodotto acquistato richieda un contributo attivo da parte dell’Utente, come la
fornitura di informazioni o dati personali, specificazioni o richieste particolari, l’inoltro dell’ordine
costituisce in capo all’Utente anche l’obbligo di collaborare di conseguenza.
- Una volta inoltrato l’ordine, agli Utenti sarà inviata una conferma di ricezione dell’ordine.
Tutte le notifiche relative alla procedura d’acquisto sopra descritta saranno inviate all’indirizzo di
posta elettronica fornito dall’Utente a tal fine.
Prezzi
Durante la procedura d’acquisto e prima dell’inoltro dell’ordine, gli Utenti vengono debitamente informati
di tutte le commissioni, tasse e costi (comprese eventuali spese di spedizione) che saranno loro addebitati.
I prezzi su questo Sito Web:
- a seconda della sezione che l’Utente sta consultando includono tutte le commissioni, tasse e costi
applicabili o sono indicati al netto di commissioni, tasse e costi applicabili.
Mezzi di pagamento
I dettagli relativi ai mezzi di pagamento accettati sono evidenziati durante la procedura d’acquisto.
Alcuni mezzi di pagamento sono legati ad ulteriori condizioni o comportano costi aggiuntivi. Le
informazioni dettagliate sono riportate nella relativa sezione di questo Sito Web.
Tutti i pagamenti vengono gestiti autonomamente da servizi terzi. Pertanto, questo Sito Web non raccoglie
dati relativi al pagamento – quali numeri di carta di credito – ma riceve una notifica una volta che il
pagamento è andato a buon fine.
Nel caso in cui il pagamento effettuato con uno dei mezzi disponibili fallisca o venga rifiutato dal
fornitore di servizi di pagamento, il Titolare non è obbligato a eseguire l’ordine. Nel caso in cui il
pagamento non vada a buon fine, il Titolare si riserva il diritto di richiedere all'Utente il rimborso di
qualsiasi spesa o danno correlato.
Riserva di proprietà
Fino alla ricezione del pagamento del prezzo integrale di acquisto da parte del Titolare, l’Utente non
acquista la proprietà dei Prodotti ordinati.
Diritto contrattuale di recesso
Il Titolare concede agli Utenti il diritto contrattuale di recedere dal contratto d’acquisto secondo i
termini e le condizioni esplicitati nella relativa sezione di questo Sito Web entro 30 giorni dalla
conclusione del contratto.
Consegna
Le consegne vengono effettuate all'indirizzo indicato dall'Utente e con le modalità indicate nel riepilogo
dell'ordine.
Al momento della consegna, gli Utenti devono verificare il contenuto del pacco e segnalare tempestivamente
eventuali anomalie ai recapiti riportati nel presente documento o come descritto nella bolla di consegna.
Gli Utenti possono rifiutare di accettare il pacco se visibilmente danneggiato.
La consegna può avvenire nei paesi o territori specificati nella relativa sezione di questo Sito Web.
I tempi di consegna sono indicati su questo Sito Web oppure nel corso della procedura d’acquisto.
Mancata consegna
Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori di consegna derivanti da inesattezze od
omissioni commesse dall’Utente nel completamento dell’ordine d’acquisto, né per eventuali danni o ritardi
intervenuti dopo la consegna al corriere se quest’ultimo è stato incaricato dall’Utente.
Nel caso in cui i beni non siano recapitati o ritirati nel momento o entro il termine stabilito, saranno
restituiti al Titolare, il quale contatterà l’Utente per programmare un secondo tentativo di consegna o
concordare ulteriori provvedimenti.
Se non diversamente specificato, ogni tentativo di consegna a partire dal secondo sarà a carico
dell’Utente.
Diritti dell’Utente
Diritto di recesso
A meno che non ricorra un’eccezione, l’Utente potrebbe godere del diritto di recedere dal contratto entro
il termine sotto specificato (di norma 14 giorni) per qualsiasi motivo e senza giustificazione. L’Utente può
trovare ulteriori informazioni sul diritto di recesso in questa sezione.
Chi gode del diritto di recesso
Ove non ricorra una delle eccezioni sotto elencate, gli Utenti che agiscono come Consumatori Europei godono
per legge del diritto di recedere dai contratti conclusi online (contratti a distanza) entro il periodo di
tempo specificato più avanti per qualsiasi motivo e senza bisogno di giustificazione.
Gli Utenti che non soddisfano tali requisiti non godono dei diritti descritti in questa sezione.
Esercizio del diritto di recesso
Per esercitare il diritto di recesso l’Utente deve inviare al Titolare una comunicazione inequivocabile
della propria intenzione di recedere dal contratto.
A tal fine, l’Utente può utilizzare il modulo di recesso tipo reperibile nella sezione delle definizioni di
questo documento. L’Utente è tuttavia libero di esprimere la propria intenzione di recedere dal contratto in
ogni altra forma idonea. Al fine di rispettare il periodo entro il quale dev’essere esercitato il diritto,
l’Utente deve inviare la dichiarazione di recesso prima che scada il termine di recesso.
Quando scade il termine di recesso?
-
In caso di acquisto di beni, il termine di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in
cui l’Utente o un terzo – da questi incaricato e diverso dal corriere –prende possesso dei beni.
-
In caso di acquisto di più beni ordinati insieme ma consegnati separatamente o in caso
di acquisto di un singolo bene composto di diversi lotti o pezzi consegnati separatamente il termine di
recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui l’Utente o un terzo – da questi incaricato e diverso dal
corriere – prende possesso dell’ultimo dei beni, lotti o pezzi.
Effetti del recesso
Il Titolare rimborsa tutti i pagamenti ricevuti compresi, se effettuati, quelli relativi alle spese di
consegna agli Utenti che abbiano correttamente esercitato il diritto di recesso.
Tuttavia, il maggior costo derivante dalla scelta di un particolare metodo di consegna diverso dalla
consegna standard più economica offerta dal Titolare, resterà a carico dell’Utente.
Il rimborso avviene senza indebito ritardo ed in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui il Titolare è
stato informato della decisione dell’Utente di recedere dal contratto. Salvo ove diversamente pattuito con
l’Utente, il rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione
iniziale. L’Utente non deve sostenere alcun costo quale conseguenza del recesso.
… sui contratti d’acquisto di beni materiali
A meno che il Titolare non si sia offerto di ritirare i beni, l’Utente è tenuto a riconsegnarli al Titolare
o ad altra persona da questi autorizzata a riceverli senza indebito ritardo ed in ogni caso entro 14 giorni
dal giorno in cui ha comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto.
Il termine è rispettato se la consegna dei beni al corriere o ad altra persona autorizzata avviene prima
della scadenza del periodo di 14 giorni sopra descritto. Il rimborso può essere trattenuto sino a ricezione
dei beni o sino a quando l’Utente abbia fornito prova di averli restituiti.
L’Utente risponde della diminuzione del valore dei beni derivante da un utilizzo dei beni diverso da quello
necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento.
Le spese di spedizione del reso sono a carico dell’Utente.
In base alla normativa europea, il venditore garantisce la conformità dei beni venduti per un periodo
minimo di 2 anni dalla consegna. Pertanto, il venditore è tenuto a garantire che i beni acquistati abbiano
la qualità, la funzionalità o le caratteristiche promesse o ragionevolmente prevedibili per almeno due anni
dal momento della consegna all’acquirente.
Qualora gli Utenti agiscano come Consumatori Europei, la garanzia legale di conformità della merce si
applica agli articoli disponibili su questo Sito Web in conformità alle leggi del paese in cui risiedono
abitualmente.
Le leggi nazionali di tale paese possono concedere a tali Utenti diritti più ampi.
I Consumatori che non agiscono in qualità di Consumatori Europei potrebbero godere di diritti di garanzia
di conformità ai sensi della normativa del paese in cui risiedono abitualmente.
Limitazione di responsabilità e manleva
Utenti australiani
Limitazione della responsabilità
Nessuna disposizione di questi Termini esclude, limita o modifica alcuna garanzia, condizione, manleva,
diritto o tutela che l’Utente possa avere ai sensi del Competition and Consumer Act 2010 (Cth) o di altre
simili legislazioni statali e territoriali e che costituisca un diritto che non può in alcun modo essere
escluso, limitato o modificato (diritto non escludibile). Nei limiti massimi consentiti dalla legge, la
nostra responsabilità nei confronti dell’Utente, inclusa la responsabilità per la violazione di un diritto
non escludibile e ogni altra responsabilità non altrimenti esclusa ai sensi di questi Termini e Condizioni,
è limitata, a discrezione del Titolare, ad una nuova fornitura dei servizi o al pagamento del costo per la
ripetizione della loro fornitura.
Utenti USA
Esclusione di garanzia
Il Titolare fornisce questo Sito Web “così com’è” e secondo disponibilità. L’utilizzo del Servizio
è a rischio e pericolo dell’Utente. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, il Titolare esclude
espressamente le condizioni, pattuizioni e garanzie di qualsiasi tipo – siano esse espresse, implicite,
statuarie o di altro tipo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie
implicite di commerciabilità, di idoneità per un fine particolare o di non-violazione dei diritti di
terzi. Nessuna consulenza o informazione, sia essa orale o scritta, che l’Utente abbia ottenuto dal
Titolare o tramite il Servizio creerà garanzie non espressamente previste nel presente documento
Fermo restando quanto sopra, il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti,
contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti non garantiscono che il contenuto sia accurato,
affidabile o corretto; che il Servizio sarà disponibile, in maniera ininterrotta e sicura, in qualsiasi
momento o luogo particolare; che eventuali difetti o errori saranno corretti; o che il Servizio sia privo
di virus o altri componenti dannosi. Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto tramite
l’utilizzo del Servizio è scaricato a rischio e pericolo dell’Utente e l’Utente è l’unico responsabile per
qualsiasi danno al sistema informatico o al dispositivo mobile o per la perdita di dati risultante da tale
operazione o dall’uso del Servizio da parte dell’Utente.
Il Titolare non garantisce, approva, assicura o si assume la responsabilità per nessun prodotto o
servizio pubblicizzato o offerto da parti terze attraverso il Servizio né nessun sito web o servizio
collegato tramite hyperlink. Inoltre il Titolare non prende parte né in alcun modo monitora nessuna
transazione tra Utenti e fornitori terzi di prodotti o servizi.
Il Servizio potrebbe diventare inaccessibile o non funzionare correttamente con il browser,
dispositivo e/o sistema operativo dell’Utente. Il Titolare non può essere ritenuto responsabile per nessun
danno, sia esso percepito o effettivo, derivante dal contenuto, funzionamento o utilizzo del
Servizio.
Leggi federali, alcuni stati e altre giurisdizioni non consentono l’esclusione e la limitazione di
determinate garanzie implicite. Le esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi agli Utenti. Questo
Accordo conferisce agli Utenti diritti legali particolari. Gli Utenti potrebbero godere di diritti
ulteriori che variano da stato a stato. Le limitazioni ed esclusioni previste da questo Accordo si
applicano nei limiti previsti dalla legge.
Limitazione della responsabilità
Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi
sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti
potranno essere ritenuti responsabili per
- qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di
avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o
all’impossibilità di usare il Servizio; e
- qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o
uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute;
- qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;
- lesioni personali o danni materiali, di qualsiasi natura, derivanti dall’accesso o dall’utilizzo
del Servizio da parte dell’Utente;
- qualsiasi accesso non autorizzato ai server di sicurezza del Titolare e/o a qualsivoglia
informazione personale ivi memorizzata
- qualsiasi interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio;
- qualsiasi bug, virus, trojan o simili che possono essere trasmessi al o tramite il
Servizio;
- qualsiasi errore o omissione in qualsiasi contenuto o per qualsiasi perdita o danno subiti a
seguito dell’uso di qualsiasi contenuto pubblicato, inviato via email, trasmesso o altrimenti reso
disponibile attraverso il Servizio; e/o
- la condotta diffamatoria, offensiva o illegale di qualsiasi Utente o di terzi. In nessun caso il
Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori
e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi richiesta di risarcimento,
procedimento, responsabilità, obbligo, danno, perdita o costo per un importo superiore a quello pagato
dall’Utente al Titolare nel corso dei 12 mesi precedenti, o per il periodo di durata di questo Accordo
tra il Titolare e l’Utente, a seconda di quale dei due è più breve.
Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla
legge nella giurisdizione applicabile, indipendentemente dal fatto che la presunta responsabilità derivi
da contratto, atto illecito, negligenza, responsabilità oggettiva o da qualsiasi altro fondamento, anche
se il Titolare era stato avvisato della possibilità del verificarsi di tale danno.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni collaterali e
consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all’Utente.
Questi Termini conferiscono all’Utente diritti legali specifici e l’Utente potrebbe godere di altri
diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione. Le deroghe, esclusioni o limitazioni di
responsabilità previste da questi Termini non si applicano oltre i limiti previsti dalla legge
applicabile.
Manleva
L’Utente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti,
affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti da e contro
qualsivoglia rivendicazione o pretesa, danno, obbligazione, perdita, responsabilità, onere o debito e
spesa, compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da
- l’uso o l’accesso al Servizio da parte dell’Utente, compresi gli eventuali dati o contenuti
trasmessi o ricevuti dall’Utente;
- la violazione di questi Termini da parte dell’Utente, comprese, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, eventuali violazioni da parte dell’Utente di qualsivoglia dichiarazione o garanzia prevista
da questi Termini;
- la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi diritto di terzi, compreso, ma non limitato a,
qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà intellettuale;
- la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente
- qualsiasi contenuto inviato dall’account dell’Utente, incluse, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise e compreso anche il caso in cui l’accesso venga
effettuato da terzi con username e password personali dell’Utente o altre misure di sicurezza, se
presenti;
- la condotta dolosa dell’Utente; o
- la violazione di qualsivoglia disposizione legale da parte dell’Utente o dei suoi affiliati,
funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti, nei limiti consentiti
dalla legge applicabile
Disposizioni comuni
Nessuna rinuncia implicita
Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini da parte del Titolare non
costituisce rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia può essere considerata definitiva in relazione ad uno
specifico diritto o a qualsiasi altro diritto.
Interruzione del Servizio
Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio
per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea
notizia agli Utenti.
Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di
terminazione del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri Dati
Personali e le informazioni secondo le disposizioni di legge.
Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo
del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout
etc.).
Rivendita del Servizio
Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare questo
Sito Web o il Servizio in toto o in parte senza previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente
o attraverso un legittimo programma di rivendite.
Privacy policy
Le informazioni sul trattamento dei Dati Personali sono contenute nella privacy policy di questo Sito Web.
Proprietà intellettuale
Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei Termini, i diritti di proprietà
intellettuale ed industriale, quali ad esempio diritti d’autore, marchi, brevetti e modelli relativi a
questo Sito Web sono detenuti in via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi
della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.
Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo, ditta, marchio di servizio,
illustrazione, immagine o logo che appaiono in collegamento con questo Sito Web sono e restano di esclusiva
proprietà del Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati
internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.
Modifiche dei Termini
Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal caso, il Titolare darà
opportuna notizia delle modifiche agli Utenti.
Le modifiche avranno effetti sul rapporto con l’Utente solo per il futuro.
L’utilizzo continuato del Servizio implica l’accettazione dell’Utente dei Termini aggiornati. Se l’Utente
non desidera accettare le modifiche, deve cessare l’utilizzo del Servizio. La mancata accettazione dei
Termini aggiornati potrebbe comportare la facoltà di ciascuna parte di recedere dall’Accordo.
La versione precedente applicabile continua a disciplinare il rapporto fino all’accettazione dell’Utente.
Tale versione può essere richiesta al Titolare.
Se richiesto dalla legge applicabile, il Titolare specificherà la data entro cui le modifiche ai Termini
entreranno in vigore.
Cessione del contratto
Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o appaltare singoli o tutti i
diritti e le obbligazioni secondo questi Termini, avendo riguardo per gli interessi legittimi degli Utenti.
Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.
L’Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni secondo i
Termini senza il consenso scritto del Titolare.
Contatti
Tutte le comunicazioni inerenti all’uso di questo Sito Web devono essere inviate ai recapiti indicati in
questo documento.
Clausola di salvaguardia
Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi
della legge applicabile, la nullità o inefficacia di tale disposizione non provoca inefficacia delle
restanti previsioni, che permangono pertanto valide ed efficaci.
Utenti USA
Qualsiasi disposizione invalida o inefficace sarà interpretata ed adattata nei limiti necessari per
renderla valida, efficace e conforme alla finalità originaria.
Questi Termini costituiscono l’intero accordo tra Utente e Titolare con riferimento all’oggetto regolato e
prevalgono su ogni altra comunicazione, compresi eventuali accordi precedenti, tra le parti in merito
all’oggetto regolato.
Questi Termini saranno attuati nella più ampia misura consentita dalla legge.
Utenti europei
Qualora una disposizione di questi Termini dovesse essere o divenire nulla, invalida o inefficace, le parti
si adopereranno per individuare in via amichevole una disposizione valida ed efficace sostitutiva di quella
nulla, invalida o inefficace.
In caso di mancato accordo nei termini predetti, se permesso o previsto dalla legge applicabile, la
disposizione nulla, invalida o inefficace sarà sostituita dalla disciplina legale applicabile.
Fermo restando quanto sopra, la nullità, invalidità o inefficacia di una specifica disposizione di questi
Termini non comporta nullità dell’intero Accordo, a meno che le disposizioni nulle, invalidi o inefficaci
nel quadro dell’Accordo siano essenziali o di tale importanza, che le parti non avrebbero concluso il
contratto se avessero saputo che la disposizione sarebbe stata invalida, ovvero in casi in cui le
disposizioni residue comporterebbero un onere eccessivo ed inaccettabile per una delle parti.
Legge applicabile
I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella
relativa sezione di questo documento a prescindere dalle norme di conflitto.
Eccezione per Consumatori Europei
Tuttavia, a prescindere da quanto precede, se l’Utente agisce come Consumatore Europeo ed ha residenza
abituale in un paese la cui legge prevede un livello di tutela dei consumatori superiore, prevale tale
superiore livello di tutela.
Foro competente
La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini
spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di
questo documento.
Eccezione per Consumatori Europei
Quanto precede non si applica a Utenti che agiscono come Consumatori Europei o Consumatori situati in
Svizzera, Norvegia o Islanda.
Risoluzione delle controversie
Composizione amichevole delle controversie
Gli Utenti possono segnalare eventuali controversie al Titolare, che cercherà di risolvere in via
amichevole.
Per quanto resti impregiudicato il diritto degli Utenti di promuovere un’azione in giudizio, in caso di
controversie inerenti all’uso di questo Sito Web o al Servizio, gli Utenti sono pregati di contattare il
Titolare ai recapiti indicati in questo documento.
L’Utente può indirizzare un reclamo all’indirizzo e-mail del Titolare indicato in questo documento,
includendo una breve descrizione e, se del caso, i dettagli dell’ordine, acquisto o account interessato.
Il Titolare provvederà ad evadere la richiesta senza indebito ritardo ed entro 2 giorni dalla sua
ricezione.
La Commissione Europea ha introdotto una piattaforma online per la risoluzione alternativa delle
controversie che favorisce la composizione extragiudiziale di dispute relative a e derivanti da vendite e
contratti di servizio online.
Pertanto, ogni Consumatore Europeo o con sede in Norvegia, Islanda o Liechtenstein può servirsi di tale
piattaforma per risolvere controversie derivanti da contratti conclusi online. La piattaforma è disponibile qui.
Definizioni e riferimenti legali
Questo Sito Web (o questa Applicazione)
La struttura che consente la fornitura del Servizio.
Accordo
Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l’Utente disciplinato dai
Termini.
Utente Commerciale
Qualsiasi Utente che non corrisponde alla definizione di Consumatore.
Europeo (o Europa)
Definisce un Utente fisicamente presente o con sede legale nell’Unione Europea, a prescindere dalla
nazionalità.
Modulo di recesso tipo
Indirizzato a:
Significa Palermo ETS - Viale Regione Siciliana 2253 - 90135 Palermo
[email protected]
Con la presente io/noi notifichiamo il recesso dal mio/nostro contratto di vendita dei seguenti
beni/servizi:
_____________________________________________ (inserire qui una descrizione dei beni/servizi dal
cui acquisto si intende recedere)
- Ordinato il: _____________________________________________ (inserire la data)
- Ricevuto il: _____________________________________________ (inserire la data)
- Nome del/dei consumatore/i:_____________________________________________
- Indirizzo del/dei consumatore/i:_____________________________________________
- Data: _____________________________________________
(firmare solamente se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
Titolare (o Noi)
Indica la persona fisica o giuridica che fornisce questo Sito Web e/o offre il Servizio agli Utenti.
Prodotto
Un bene o servizio acquistabile attraverso questo Sito Web, come ad esempio un bene materiale, file
digitali, software, servizi di prenotazione etc.
La vendita di un Prodotto può essere parte del Servizio, così come sopra definito.
Servizio
Il servizio offerto tramite questo Sito Web così come descritto nei Termini e su questo Sito Web.
Termini
Tutte le condizioni applicabili all’utilizzo di questo Sito Web e/o alla fornitura del Servizio così
come descritti in questo documento nonché in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato,
nella versione rispettivamente più aggiornata.
Utente (o Tu)
Indica qualsiasi persona fisica che utilizzi questo Sito Web.
Consumatore
Qualsiasi persona fisica che, in qualità di Utente, utilizza beni o servizi per scopi personali e, in
generale, agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale.